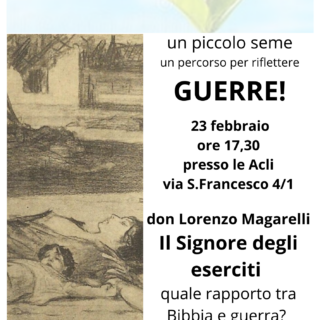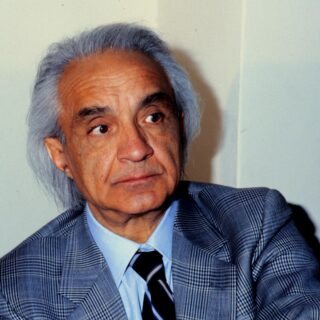“È dentro situazioni di apparente morte che occorre riscoprire la speranza cristiana, fondata sulla passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo”: a ricordarlo è padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, alla vigilia della Settimana Santa. Domani mattina, infatti, al Santo Sepolcro, a Gerusalemme, con la Messa Pontificale del patriarca latino, card. Pierbattista Pizzaballa, si apriranno i riti della Settimana Santa. Sempre domani, ma nel pomeriggio, avrà luogo la Processione delle Palme dal Monte degli Ulivi alla basilica di Sant’Anna, una delle più significative manifestazioni pubbliche cristiane della Terra Santa. Si tratta della seconda Pasqua vissuta in un clima di guerra e di tensione, ma al tempo stesso è la Pasqua del Giubileo 2025, evento che Papa Francesco ha voluto legare al tema della speranza.
Padre Patton, ci accingiamo a vivere la seconda Pasqua in piena guerra tra Hamas e Israele e in un clima crescente di violenza in Cisgiordania e nei Paesi vicini, come Siria e Libano. Ma sarà anche una Pasqua incastonata nel cammino del Giubileo intitolato “Pellegrini di Speranza”. È possibile vivere la speranza in un contesto simile?
Non solo è possibile, è necessario. La speranza cristiana non è un vago desiderio che domani le cose vadano meglio. È, per dirla con san Paolo, sperare contro ogni speranza. È la speranza di Abramo, che, pur anziano e sterile, crede alla promessa di Dio. È dentro situazioni di apparente morte che occorre riscoprire la speranza cristiana, fondata sulla passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. San Francesco d’Assisi la chiamava “speranza certa”, perché si basa sul fatto che Cristo ha già vinto il male e la morte, anche se il male e la morte ancora feriscono la nostra umanità.
Più che un’esperienza di Resurrezione, questa Pasqua sembra un prolungamento del Calvario. Quanto deve ancora durare questa sofferenza che tocca le popolazioni civili?
Sì, si sta vivendo un prolungamento del Calvario. Blaise Pascal diceva che Cristo è in agonia fino alla fine del mondo. Non dobbiamo avere una visione superficiale della storia, come gli illuministi che pensavano a un progresso automatico. Dentro la storia si consuma un dramma: la lotta tra il bene e il male di cui parla l’Apocalisse. Solo alla fine, con la Gerusalemme celeste che discende dal cielo, si realizza pienamente la pace, che è dono di Dio. La Bibbia ci insegna che è necessaria la partecipazione dell’uomo, ma la pace autentica discende dall’alto e nasce da cuori aperti a Dio e alla dignità dell’altro.
- (Foto AFP/SIR)
- Foto ANSA/SIR
Purtroppo, a quanto vediamo sul terreno, le parti in lotta non sono orientate alla pace e alla ricerca di un accordo negoziato…
Quando la pace arriva solo per la sconfitta dell’altro, non è vera pace. La pace autentica suppone la ricerca di un bene pieno per l’uno e per l’altro. Nella pace armata ci sono vincitori e vinti, e di solito anche un bottino o un territorio conquistato. Ma quella non è la pace evangelica: è una sua caricatura, che nasce dal male. Nella Bibbia lo spirito di contesa è considerato qualcosa di diabolico. La pace, invece, viene da Dio.
In questo clima globale avvelenato, come rendere concreta la speranza?
Il clima culturale mondiale è segnato dal mito della forza, dell’uomo forte che si impone, del superuomo, come un secolo fa. Per questo bisogna agire sull’educazione. Occorre educare al riconoscimento della dignità dell’altro, che non viene meno nemmeno quando sbaglia, nemmeno quando diventa un terrorista. La paura dell’altro è la molla che scatena i meccanismi di difesa violenta. Paolo VI già ci esortava a disarmare i cuori. Questa operazione è culturale ed educativa, ma è anche responsabilità dei leader religiosi e politici. Se i leader usano un linguaggio violento, non vanno nella direzione della pace.

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
Che senso ha oggi credere nella promessa di Cristo risorto?
L’esperienza che stiamo vivendo non è diversa da quella dei primi cristiani. I discepoli scapparono quando Gesù venne arrestato. I due di Emmaus si allontanavano delusi da Gerusalemme. I cristiani del I secolo videro l’assedio e la distruzione di Gerusalemme, ma continuarono a credere che la promessa di Gesù non era l’inganno di un falso profeta, bensì la promessa autentica del Figlio di Dio incarnato. Quando facciamo riflessioni spirituali, non evadiamo la realtà: la illuminiamo e la orientiamo verso un possibile cambiamento.
Quest’anno sarà una Pasqua ancora senza pellegrini ma ci saranno i fedeli locali a rappresentarli.
È la seconda Pasqua consecutiva senza pellegrini. Già la pandemia ci aveva abituati a vivere Natali e Pasque in solitudine. Ma quest’anno celebriamo la Pasqua con una ragione in più di gioia: cade nella stessa data per cristiani d’Oriente e d’Occidente, e ricorrono i 1.700 anni dal Concilio di Nicea, che ha definito l’umanità e la divinità di Cristo e stabilito la data della Pasqua. Sarà una Pasqua di unità. Anche senza i pellegrini tradizionali, ci saranno i fedeli locali, i pellegrini ortodossi da Cipro, i copti, gli etiopi e tanti lavoratori migranti. Saremo noi stessi a rappresentare i pellegrini del mondo intero. Invito però i pellegrini a superare paure e remore e a rimettersi in cammino verso la Terra Santa, affidandosi al Padre eterno.
Daniele Rocchi (SIR)
Foto in evidenza Calvarese/SIR