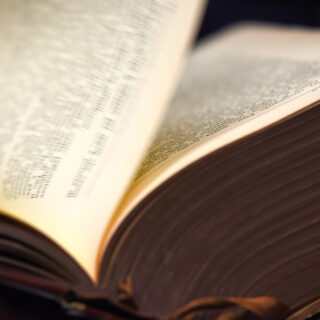Vent’anni fa, il 19 aprile, il Signore chiamava Joseph Ratzinger a succedere a Papa Giovanni Paolo II. Il teologo tedesco scelse il nome Benedetto, il fondatore del monachesimo occidentale e patrono dell’Europa. Questo nome pontificale si richiamò anche a papa Giacomo della Chiesa – Benedetto XV – che definì la Prima Guerra Mondiale come l’inutile strage. La volontà di Papa Ratzinger fu di richiamare l’Europa a quelle radici cristiane di cui il predecessore polacco parlò più volte. Incessante fu il suo lavoro per cercare di far uscire il nostro continente dall’essere “museo del cristianesimo”.
Dopo gli anni trionfanti del bimillenario cristiano, Benedetto XVI dovette assistere ai penosi e quotidiani attacchi mediatici dentro e fuori la Chiesa, alla polarizzazione crescente tra progressisti e tradizionalisti, agli scandali di varia natura, agli attacchi alla sua persona (paradossalmente anche di matrice culturale: vedi i casi della Sapienza e di Ratisbona in primis). Fine teologo e anima sensibile, il teologo Ratzinger ha lasciato dei testi di obbligatoria lettura per quanti desiderano capire la ricchezza anche culturale del cristianesimo. Pastore schivo e umile, Papa Benedetto offrì lucide e profonde meditazioni nelle sue omelie e nei suoi discorsi. A vent’anni dall’elezione al soglio petrino, riascoltare i suoi interventi è davvero arricchente e dev’essere fatto come nutrimento per l’intelligenza e la sapienza spirituale.
La vita di Benedetto XVI riassume gli slanci e le tensioni della nostra epoca e ha portato su di sé anche le fatiche e le contraddizioni di un cristianesimo e una cultura ancora bisognosi di ritrovare modalità espressive. Tutto ciò va ripensato e ripreso, per annunciare un cristianesimo pensato e pensante e non ideologico; un cristianesimo resiliente e non pauroso; un cristianesimo profetico e non formale; un cristianesimo sinfonico e non polarizzato; un cristianesimo bello e non banale. Ricordando la corsa fatta quando, allora giovane studente romano, mi recai in piazza San Pietro per ascoltare l’annuncio del protodiacono e ricevere la prima benedizione Urbi et Orbi, rilancio a tutti lo splendido incipit della Deus Caritas est, la sua prima lettera enciclica.
«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4, 16). Queste parole della Prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare chiarezza il centro della fede cristiana: l’immagine cristiana di Dio e anche la conseguente immagine dell’uomo e del suo cammino. Inoltre, in questo stesso versetto, Giovanni ci offre per così dire una formula sintetica dell’esistenza cristiana: «Noi abbiamo riconosciuto l’amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto».
Abbiamo creduto all’amore di Dio — così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo Vangelo Giovanni aveva espresso quest’avvenimento con le seguenti parole: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui … abbia la vita eterna» (3, 16). Con la centralità dell’amore, la fede cristiana ha accolto quello che era il nucleo della fede d’Israele e al contempo ha dato a questo nucleo una nuova profondità e ampiezza. L’Israelita credente, infatti, prega ogni giorno con le parole del Libro del Deuteronomio, nelle quali egli sa che è racchiuso il centro della sua esistenza: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (6, 4-5). Gesù ha unito, facendone un unico precetto, il comandamento dell’amore di Dio con quello dell’amore del prossimo, contenuto nel Libro del Levitico: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (19, 18; cfr Mc 12, 29-31). Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4, 10), l’amore adesso non è più solo un «comandamento», ma è la risposta al dono dell’amore, col quale Dio ci viene incontro.
In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell’odio e della violenza, questo è un messaggio di grande attualità e di significato molto concreto. Per questo nella mia prima Enciclica desidero parlare dell’amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere comunicato agli altri. Ecco così indicate le due grandi parti di questa Lettera, tra loro profondamente connesse. La prima avrà un’indole più speculativa, visto che in essa vorrei precisare — all’inizio del mio Pontificato — alcuni dati essenziali sull’amore che Dio, in modo misterioso e gratuito, offre all’uomo, insieme all’intrinseco legame di quell’Amore con la realtà dell’amore umano. La seconda parte avrà un carattere più concreto, poiché tratterà dell’esercizio ecclesiale del comandamento dell’amore per il prossimo. L’argomento si presenta assai vasto; una lunga trattazione, tuttavia, eccede lo scopo della presente Enciclica. È mio desiderio insistere su alcuni elementi fondamentali, così da suscitare nel mondo un rinnovato dinamismo di impegno nella risposta umana all’amore divino.
Nei giorni in cui piangiamo la scomparsa del Santo Padre Francesco, queste parole di Papa Benedetto ci fanno vedere una straordinaria continuità nel magistero dei due pontefici che hanno saputo innalzare la voce come araldi del Vangelo, come custodi dei più poveri, come apostoli della pace, come maestri di quel Vangelo per il quale diedero la vita.
don Lorenzo Magarelli
Foto ANSA/SIR