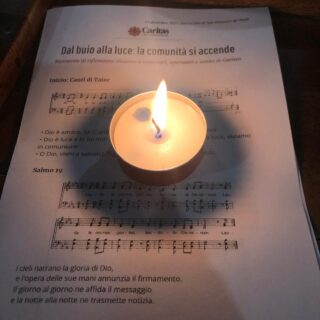Dopo tre mesi di colloqui il 19 luglio è stata firmato a Doha un cessate il fuoco tra il governo della Repubblica democratica del Congo e il gruppo armato M23, che ha preso il controllo di città e aree ricche di minerali nell’est del Paese, soprattutto nel Kivu. Dopo trent’anni di guerra che hanno causato milioni di morti, violenze e sfollati, a prendersi i meriti dell’accordo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che addirittura ha detto di aspirare al Premio Nobel per la pace. Eppure la società civile e la Chiesa congolese esprimono dubbi e perplessità riguardo a quella che sembra in apparenza una buona notizia. “Nel Kivu le violenze non sono cessate e c’è ancora gente in fuga. Alcuni leader del gruppo M23, sostenuti dal Rwanda, hanno detto pubblicamente che non hanno intenzione di lasciare il potere. È una pace a parole ma non ancora nei fatti. Gli accordi non prevedono iniziative per il reintegro degli sfollati né il disarmo e la smobilitazione”, spiega al Sir Pierre Kabeza, attivista congolese nato a Bukavu, che vive da tanti anni in Italia. “Per noi una pace che non ha come pilastro la giustizia è una pace falsa”, afferma. L’accordo rischia di essere quindi “una pace fragile” calata dall’alto, poiché non ha minimamente coinvolto la popolazione.

Nonostante trent’anni di massacri e di crimini, osserva Kabeza, “negli accordi non emerge il tema della giustizia. Che non significa vedere qualcuno in carcere ma anche solo riconoscere le responsabilità e chiedere scusa”. L’esempio è l’esperienza del Sudafrica di Nelson Mandela, che ha ottenuto per il suo popolo verità e riconciliazione. “Qualcuno deve chiedere perdono per quello che ha fatto. Invece è come se si stesse prendendo in giro il popolo congolese”. Lo scetticismo deriva anche dall’aver visto negli anni tanti accordi firmati con gli stessi gruppi, che hanno solo cambiato nome: “Se guardiamo bene, sono sempre le stesse persone.
E se gli accordi non includono l’aspetto della giustizia, la pace è sempre fragile”.
La società civile non è stata coinvolta. Inoltre, gli accordi di pace non sono stati discussi “né in Parlamento né in Senato e la società civile del Kivu non è stata coinvolta nel processo. Era necessaria invece la partecipazione del popolo che soffre”. Il terzo dubbio riguarda il ruolo degli Stati Uniti nel controllo dei minerali e delle terre rare della R.D. Congo. “Abbiamo paura che i nostri minerali vengano venduti o ceduti a qualcuno, solo perché c’è chi vuole conservare il potere”. Kabeza ricorda che anche il presidente Biden era stato in Angola per firmare accordi sui minerali del Congo. “Ora Trump sta seguendo quello che ha fatto Biden, che non riguarda i Repubblicani o i Democratici, ma gli interessi degli Stati Uniti nel mondo. E noi siamo sempre lì, a perdere”. Anche l’ipotesi di Trump di candidarsi per il Nobel per la pace è inverosimile: “Un uomo di pace deve cercare la pace ovunque nel mondo. Invece Trump cerca la pace in Congo mentre bombarda l’Iran o lascia che a Gaza accadano violenze sui bambini. Ciò che sta accadendo a Gaza è la negazione della nostra umanità. Non ci sono popoli di serie A e popoli di serie B. E dobbiamo cercare la pace per tutti i popoli del mondo”. A livello nazionale, a suo avviso, è necessario “un dialogo tra i congolesi. Dobbiamo capire quali sono i problemi interni del Congo: politici, sociali, economici. E trovare soluzioni ai nostri problemi. Non è Trump a darci la soluzione, come vogliono farci credere”.
Gli accordi “non prevedono niente per il popolo. Sembrano solo un gioco tra chi vuole i minerali e chi vuole il potere politico”.
Serve una pace fondata sulla giustizia. “In Congo, purtroppo, lo schema è sempre lo stesso: chi prende le armi diventa capo, chi commette crimini diventa intoccabile – afferma l’attivista congolese -. Per questo insistiamo sulla giustizia: chi ha commesso massacri e crimini con gli accordi diventerà ancora una volta classe dirigente. È un modo di prendere in giro il popolo che è vittima”. Anche l’Unione africana, a suo avviso, “non è un’Unione per i popoli africani” ma “fa il gioco dei capi, perché cammina sempre con i poteri”: “Noi la consideriamo come una sorta di sindacato dei capi africani. Quando i capi fanno repressione, non fa nulla. Quando un capo subisce, allora agisce”.

Le perplessità della Chiesa congolese. Lo stesso cardinale Fridolin Ambongo, arcivescovo di Kinshasa, durante una recente conferenza stampa in Vaticano ha criticato l’Accordo di Washington del 27 giugno tra Repubblica Democratica del Congo e Rwanda. A suo avviso si tratta di una “falsa soluzione”, che non tiene conto della realtà sul campo né delle sofferenze delle popolazioni colpite da “secoli di estrattivismo, schiavitù e sfruttamento”: “Sono chiaramente in favore della pace, sono sempre contento quando le armi vengono deposte, quando si decide comunque di porre fine alle violenze, ma quello che non va bene è l’ipocrisia”.
La società civile congolese: aprire un corridoio umanitario per salvare vite. Pareri simili sono stati espressi dalla società civile del Sud Kivu: in un lungo documento che porta la data del 21 luglio inviato alle principali autorità internazionali (compreso Trump e i vertici dell’Unione europea) si invita a
costruire una pace duratura nell’arco di 15 anni,
tenendo conto che la riuscita del piano dipende principalmente dal superamento di decenni di malgoverno, corruzione, bellicismo: “Politici arrivano al potere con le tasche vuote e 5 o 10 anni dopo diventano milionari e miliardari in dollari per effetto del saccheggio del Paese”, si legge nel documento intitolato “La RD. Congo, futuro della regione dei Grandi Laghi africani”. Priorità urgente, secondo i rappresentanti della società civile, è
l’apertura di “un corridoio umanitario per salvare vite di uomini, donne e bambini disperati, senza cibo e medicine”.
Anche il Consortium Pamoja kwa Amani, che riunisce organizzazioni della società civile del Nord e Sud Kivu, in una nota del 19 luglio invita “tutti i belligeranti nazionali e stranieri al rispetto stretto e senza condizioni dei tutti i loro impegni, affinché la pace a lungo cercata sia realtà effettiva, non solo sulla carta ma sul campo”.
Patrizia Caiffa (SIR)
Foto in evidenza: ANSA/SIR