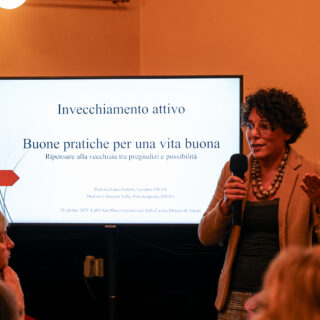Libertà e dipendenza: due parole per le quali non basterebbe un’enciclopedia, perché sembrano l’una il contrario dell’altra.
Noi infatti siamo esseri sociali e quindi connessi a qualcuno sin dalla nascita: ma relazione non coincide con dipendenza; la dipendenza, al contrario, è l’aspetto patologico della relazione. Per diventare degli esseri sociali liberi, infatti, noi abbiamo bisogno di alcuni requisiti: innanzitutto un Io ben strutturato; in secondo luogo – ma non per importanza – l’aver sviluppato delle difese sufficientemente solide e sufficientemente plastiche. Solo così possiamo compiere delle azioni sociali senza mettere in atto dei comportamenti autolesivi.
Tutto chiaro? Sembra facile, ma il problema è che l’adolescente non ha ancora sviluppato nessuno dei due requisiti sopra citati. E allora che fare? Qual è il ruolo dei genitori? Essi devono innanzitutto promuovere generatività: tra i 10 e i 17-18 anni c’è una continua necessità di contrattazione tra l’Io strutturato dei genitori e l’Io ancora incerto dei ragazzi, tra le difese solide e plastiche degli adulti di riferimento e le difese ancora incerte degli adolescenti. I ragazzi spesso, in un momento di difficoltà, per non deprimersi mettono in atto un pensiero onnipotente, ma questo dona loro solo l’illusione di essere potenti, di dominare il mondo: entrano in dei gruppi per sentirsi accolti, si collegano a tutto il mondo attraverso chat e videogiochi. Come aiutarli e come contenerli? Qui devono entrare in scena delle figure di adulti che non hanno paura, capaci di proporre strategie per evitare dipendenze autodistruttive.
I genitori, innanzitutto, hanno il compito di generare amore, comunicando al figlio che è benvoluto per il semplice fatto di esistere, indipendentemente da quello che sa e da quello che fa. Ma l’affetto incondizionato, da solo, non basta: il secondo grande compito è dare speranza, ossia nutrire in un figlio che cresce la fiducia che anche lui ce la farà a costruirsi un Io solido e che la confusione attuale è solo un momento passeggero. Fondamentale è non vietare ma contrattare, perché il divieto enfatizza il valore del proibito: su questo terreno è importante guidare gli adolescenti a formarsi un pensiero dialettico, pronto a discutere sulle regole, ma anche a capirne le funzioni.
Ma, dopo l’affetto e la speranza, per i genitori arriva un terzo compito, forse il più difficile: contenere la sofferenza. Facile col neonato che piange: lo si prende in braccio, lo si culla ed è fatta. Come rapportarsi, invece, con un adolescente che reagisce in modo aggressivo? Rabbia e aggressività sono l’altra faccia del dolore: il ragazzo/la ragazza vorrebbero presentarsi come persone tutte d’un pezzo, ma non lo sono ancora e, di fronte ad un ostacolo, perdono la bussola. Qui l’adulto deve saper mediare tra vicinanza e rispettosa distanza. Se gli adulti sono incapaci di questo, diventano genitori fusionali, che legano talmente il figlio a sé, da renderlo incapace di cavarsela da solo. Questa strategia è un’autostrada verso le dipendenze, dove spesso finiscono sia gli adolescenti minati da un affetto condizionato alle loro prestazioni, della serie “ti voglio bene solo se …”, sia quelli non riconosciuti come soggetti separati dagli adulti di riferimento.
Non va dimenticato inoltre che il cammino verso la libertà si prepara già nella prima infanzia: è qui che il bambino passa dalla totale dipendenza dalla madre alle piccole autonomie; è qui che il piccolo incontra le sue prime figure di riferimento esterne alla famiglia. Questo processo va promosso e sostenuto, non ostacolato con sciocche gelosie.
Man mano che un figlio cresce, ai genitori spetta anche un ulteriore compito: promuovere in lui la capacità di pensare, facendolo passare dall’impulsività al pensiero riflessivo. Come? Facendogli capire il peso che le sue parole e le sue azioni hanno sugli altri e quanto male possono far un commento o un comportamento fuori posto.
Ma quale strada prenderanno i figli? Tutti i genitori se lo chiedono. Come orientarli? Osservando le loro passioni e facendo in modo che queste diventino delle competenze. Nessun figlio sarà la copia dei genitori o di un fratello o sorella: il rispetto dell’alterità dell’altro è parte integrante di una relazione sana.
Quanto è difficile tutto questo! Certamente lo è, ma nessuno è chiamato alla perfezione: anzi, delle persone perfette bisogna diffidare, perché nascondono spesso una grande rigidità mentale e una inesorabile aridità affettiva.
Dialogare, tentare, sbagliare, scusarsi, rialzarsi: tutto questo fa parte di un cammino per persone vere e non per insensibili automi; un cammino dove amore, rispetto e accettazione non vengono mai messi in discussione. Solo allora anche le regole saranno più semplici da negoziare.
Iris Zocchelli

Foto Uciim
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti al nostro canale Whatsapp cliccando qui