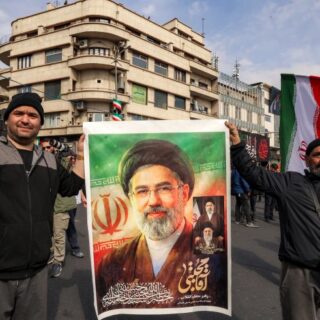Ricordo perfettamente l’11 dicembre 2001. Avevo solo 5 anni, l’immagine di tutto quel fumo che usciva da due torri “bucate” da un aereo mi impressionò. Non so se anche perché aveva bruscamente interrotto uno dei miei pomeriggi, a guardare la Melevisione, appuntamento fisso per quella me bambina. Tutto quello che arrivò dopo, ha segnato inconsciamente la mia esistenza, e quella della generazione a cui appartengo.
Ho ancora vivo nella mia mente anche il 24 febbraio 2022, la sveglia mattutina con la notizia terribile dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Avevo 25 anni. Mi sono affannata a cercare notizie, articoli, approfondimenti che mi aiutassero a capire cosa fosse successo, e poi lo sgomento, il senso di smarrimento, la paura del ritorno di una guerra così vicina a casa mia. E anche per il 7 ottobre 2023 non fu tanto diverso.
Evidentemente, la giovinezza che caratterizza chi vive da una parte del mondo che ad oggi sta sotto le bombe non è la stessa di cui fa esperienza chi, come me, è nata nella parte più fortunata del mondo. Non certo meno salva.
I racconti dei nostri nonni ci hanno messo davanti agli occhi una storia che pensavamo non sarebbe tornata più: storie di viaggi forzati, di campi di lavoro, di resistenza, di privazione della dignità e di paura, di tanta povertà. Noi invece siamo nati europei, siamo quelli dell’Erasmus con amici in tutta Europa, abituati a prendere aerei che ci portano dall’altra parte dell’Europa in un paio d’ore. Siamo anche quelli che stanno vedendo la guerra attraverso lo scrolling sui cellulari, lì dove l’algoritmo ci ha condotti nella “bolla” giusta. Immagini di corpi smembrati, di persone senza più casa, trattate come carne da macello, sacrificate sull’altare del potere più becero. C’è la paura di abituarsi a queste immagini, di non fare più caso al male del mondo, di esserne in qualche modo responsabili, anche solo per non riuscire a far nulla. Il senso di impotenza rischia di avere la meglio.
Se hai 24 anni e vivi a Kyiv puoi comodamente fare compere con i saldi da Zara in centro, mentre la sera ti rifugi nel bunker più vicino. Scegli di andare all’università sapendo che potresti correre un grande rischio. La morte impregna la quotidianità, rendendola graffiante. Prendi confidenza con la paura. E una strana calma si percepisce lontana dal suono delle sirene.
Qualche mese fa, nelle piazze delle città ucraine visitate, mentre guardavo le foto dei soldati morti in guerra in questi tre anni, e guardando alle loro date di nascita, pensavo che fossero tutti assurdamente giovani. La maggior parte aveva la mia età. Componevano quella nebulosa inquantificabile di giovani vite spezzate dalla guerra. Da una parte e dall’altra. Quello che non era cambiato dai racconti di mio nonno sulla guerra, era la sua assurdità, e il fatto che fossero soprattutto i giovani a pagarne le conseguenze.
La nostra generazione è quella che paga di più le conseguenze di una guerra voluta da pochi adulti al comando. In qualunque parte del mondo ci possiamo trovare, la guerra rappresenta una sconfitta collettiva, in ogni caso. Di fronte a questo contesto, sperare è vedere il bene dell’umanità pur nella crudezza della realtà.
In quel viaggio in Ucraina, la provocazione più grande è arrivata da Nastia, 22 anni: “Credo che un giorno tutto questo finirà, e che torneremo a vivere in pace” ci ha detto con coraggio. La speranza risuona anche nelle parole di Naila, giovane di Taybeh, che ci ha accompagnato durante la via Crucis promossa dalla Custodia di Terra Santa: “La raccolta delle olive era uno dei momenti più belli dell’anno in cui si riuniva la nostra famiglia, anche il parroco, ricordo quando ero piccola, faceva il giro delle campagne per stare con la gente. Oggi tra gli ulivi non ci sentiamo nemmeno più sicuri. Il mio villaggio si sta svuotando e le campagne sono abbandonate, ma io continuo a coltivare la speranza che presto le cose possano cambiare”.
Non posso non leggere, dietro queste testimonianze, una fede autentica, radicata in Cristo, che vincendo la morte ha salvato l’umanità intera. Siamo già salvi, in Lui.
Ci sono segni di speranza in chi non ha mai smesso di guardare a domani pur nell’orrore della guerra, e in chi, a Gaza, ha pulito le macerie in quello che rimaneva della sua casa distrutta per festeggiare l’Iftar durante i giorni dell’illusorio cessate il fuoco. Questa speranza, per noi che viviamo nella parte fortunata del mondo, ha il suono forte della responsabilità. Sperare quindi significa mobilitare una generazione libera a costruire un mondo nuovo, libero.
“Organizzare la speranza” – come diceva Don Tonino Bello e come ci ha invitato spesso a fare Papa Francesco – prende oggi la forma della costruzione di una solidarietà universale, capace di andare oltre le frontiere geografiche e umane. Sentiamo forte il bisogno di ricucire l’umanità, tradita dalle leggi del mercato e dal sistema internazionale. Per farlo, vogliamo tornare a guardare con attenzione le immagini che ci passano sotto gli occhi e sentire che quelle vicende, in fondo, sono anche nostre.
Emanuela Gitto
vicepresidente nazionale di Azione cattolica per il Settore giovani